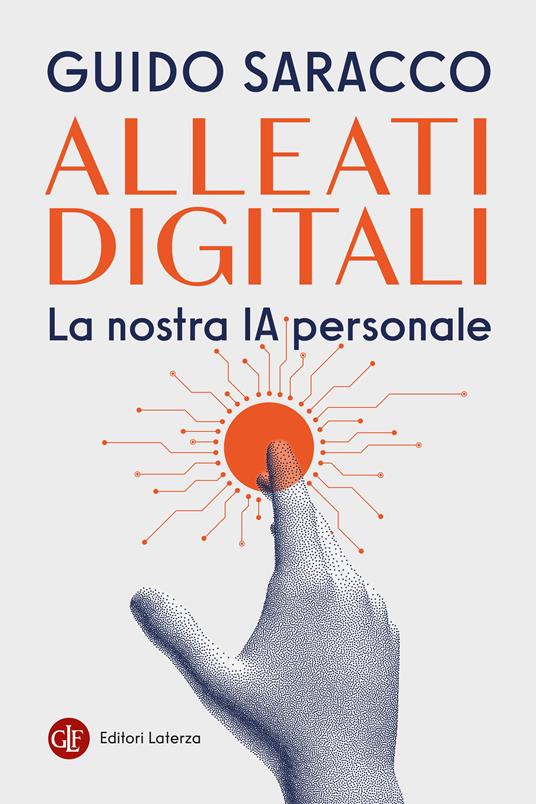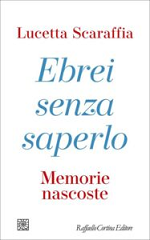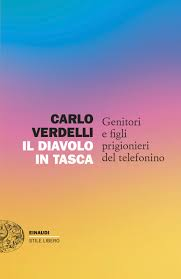Titolo Ebrei senza saperlo
Sottotitolo Memorie nascoste
Autore Lucetta Scaraffia
Argomenti Sociologia e Storia Teologia e Religioni
Editore Raffaello Cortina
Formato Libro Pagine 168
Pubblicazione 01/2026
Prezzo di copertina €16,00
ISBN 9788832858419
Il patrimonio genetico è senza dubbio individuale ma l’autrice, partendo da una storia personale, ci accompagna in una dimensione ben più ampia nel tempo e nello spazio. Nel tempo perché stiamo parlando del popolo con il culto e l’identità religiosa più antichi e nello spazio perché questo popolo appartiene a molteplici realtà sociali, religiose, politiche e geografiche. Il sottotitolo individua il focus di questo percorso “memorie nascoste”. Ragioni legate a fasi politiche e storiche, conducono molti ebrei a convertirsi al cristianesimo. Famiglie sparse un po’ in tutta Europa dalla Polonia alla Spagna, all’Italia. Si tratta di conversioni dettate da motivi di sicurezza, di lavoro, d’integrazione.
La scoperta che la nonna paterna, che credeva di origini inglesi, era invece di famiglia ebraica, se pure convertita, ispira all’autrice una ricerca sulle sue origini, partendo dal cognome, Wildt, originario dell’Europa orientale. Le indagini d’archivio rivelano che la famiglia era arrivata a Milano all’inizio dell’Ottocento, dove si era insediata ed evidentemente convertita. Questo nascondimento delle origini ebraiche anche in una famiglia di convertiti dimostra le difficoltà a essere accettati e la necessità di difendersi con la menzogna.
Emblematica è l’esperienza di Adolfo Wildt, milanese, primogenito di una famiglia povera che a 9 anni lavora come garzone da un barbiere, a 11 anni entra nella bottega dello scultore Giuseppe Grandi e a 17 impara a lavorare il marmo da Federico Gaetano Villa. Le sue mani sono abili e verso la materia prima “marmo” coltiva quasi una venerazione. Lo comprende subito Margherita Sarfatti influente critica d’arte e figura chiave del movimento «Novecento Italiano», fu una grande ammiratrice e protettrice dello scultore Adolfo Wildt definendolo il “primo maestro dell’arte del marmo”. Il loro sodalizio unì l’estetica sofisticata di Wildt, sospesa tra simbolismo e ritorno all’ordine, con le strategie culturali della Sarfatti, favorendone la fama negli anni ’20. Era di origine ebrea Adolfo? Che importa l’arte supera tutti i preconcetti.
Quanti altri ebrei emigrati si sono convertiti, spinti dalla paura e dal bisogno? Quanti di noi, ripercorrendo il passato, potrebbero scoprire tracce nascoste della propria origine ebraica? Una storia condivisa in realtà da molte famiglie. Le vicende dei convertiti, dei marrani, degli ebrei costretti a nascondersi non sono mai ridotte a semplici casi di studio: sono storie vive, cariche di dolore, ambiguità, resistenza interiore. L’autrice, nel suo lungo percorso storico, cita proprio, Jules Isaac, ebreo francese che sopravvive alla deportazione e morte della moglie e della figlia. Rimasto solo si propone di spingere la chiesa a cancellare dai testi sacri e dalle liturgie “l’insegnamento del disprezzo verso gli ebrei”. Nel suo libro Gesù e Israele, afferma l’ebraicità mai rifiutata di Gesù e dei discepoli. La chiesa, anche dopo la Shoah non mostra alcuna preoccupazione pastorale per l’antisemitismo. L’unico passo utile può essere collaborare con i cristiani e fonda “l’Amicizia ebraico-cristiani”. L’autrice offre al lettore un messaggio di speranza. Papa Giovanni XXIII riconosce l’esistenza degli ebrei e toglie alla chiesa la missione di convertirli alla fede cristiana. Viene da concludere che forse non ci sarebbero state così tante conversioni pro-forma, in un clima di riconoscimento, e che accanto a me seduto sull’autobus può esserci un ebreo. Shalom
Lucetta Scaraffia, che nel 2017 ha ricevuto le insegne di ufficiale della Legion d’onore assegnatale dal presidente della Repubblica francese per la sua attività di storica e di giornalista, ci regala una lettura preziosa, che apre gli occhi e il cuore, che invita pensare oggi più che mai a quanto importanti siano le nostre radici, il dialogo, rispettoso, autentico tra le persone di fedi e culture diverse. Siamo un’unica umanità.
Alberta