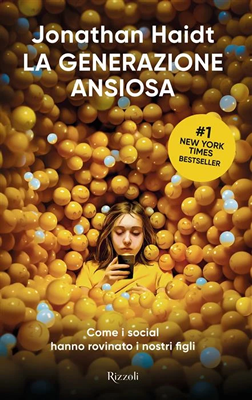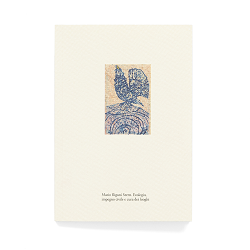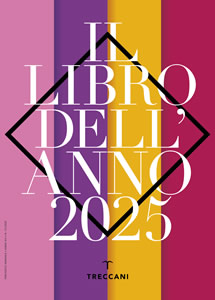Casa editrice:Treccani Libri
In libreria dal: 12/12/2025
Pagine: 590
Prezzo: € 29,00
Collana: ANNUARI
ISBN: 9788812012930
Dimensioni: 20×28 cm
Il libro dell’Anno 2025 pubblicato da Treccani, contiene anche la sezione ” Le parole dell’anno” – con i neologismi più recenti come tornanza, droga degli zombie, affidopoli, allucinazione dell’intelligenza artificiale, keybox, pro-Pal, ma anche la qualunque e occhi spaccanti. E un tributo a Sinner con ingiocabile.
I neologismi selezionati per il libro dell’anno – spiegano i linguisti dell’Osservatorio della Lingua Italiana – fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari. Il lavoro si limita a segnalare quelle parole che, nel corso del 2025, hanno avuto maggiore rilevanza nell’uso comune o nella stampa e solo il tempo dirà se resteranno per sempre.
_______________
Cronaca, politica, tecnologia ed economia hanno avuto un peso determinante nella scelta dei neologismi dell’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani, raccolti nel Libro dell’anno Treccani 2025, appena pubblicato dall’Istituto della Enciclopedia Italiana.
Molte delle nuove parole sono legate alla Politica, interna e internazionale, come pro-Pal (chi sostiene la causa politica del popolo palestinese), Brandmauer (in Germania l’isolamento politico delle forze di estrema destra di tradizione o ispirazione nazista) o sumud (resilienza, resistenza, speranza nel futuro, solidarietà, intesi come valori culturali e politici dei palestinesi che intendono restare nelle terre dove abitano).
Sulle nuove parole anche il peso della Cronaca, come per affidopoli (il presunto scandalo dello scorretto affidamento diretto di appalti), maranza (negli usi attuali, giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga), droga degli zombie (denominazione giornalistica del medicinale Fentanyl, un oppiaceo analgesico smerciato illegalmente e assunto come droga potente), tornanza (l’azione, il fatto di ritornare nel luogo d’origine), rifugio climatico (luogo pubblico o privato in grado di offrire rifugio dalle temperature estreme), kiss cam (la telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano) e keybox (cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione).
La Tecnologia ha imposto parole quali allucinazione della intelligenza artificiale (l’informazione errata prodotta da un sistema di intelligenza artificiale), nudificazione (creazione abusiva e illegale di falsi nudi, perlopiù femminili), broligarchia (la ristretta cerchia di uomini ricchi e potenti, rappresentanti delle grandi aziende nell’ambito delle tecnologie più avanzate, competitive e innovative, che condizionano o minano a condizionare gli orientamenti politici e le scelte dei governi) o metatelefono (rettangolo di plastica trasparente simile a un cellulare, ma finto) mentre dall’Economia derivano termini come bullismo economico (in senso fortemente polemico, azione di sopraffazione esercitata con l’intento di imporre condizioni sfavorevoli agli altri attori attivi sulla scena economica o finanziaria), controdazio (il dazio che colpisce come strumento di ritorsione) e cryptogate (lo scandalo legato all’emissione di criptovalute).
Tra le parole più curiose troviamo la qualunque (una cosa qualunque che viene detta a sproposito) – che rende merito all’attore e comico Antonio Albanese, creatore del personaggio televisivo e cinematografico Cetto La Qualunque -, romantasy (genere di narrativa che intreccia storie d’amore appassionate e temi tipici del fantasy avventuroso) e occhi spaccanti (occhi bellissimi che sprigionano uno sguardo intenso, come sa bene Roul Bova, che ha persino depositato il marchio).
Infine, anche un tributo a Sinner, al quale si deve il neologismo ingiocabile: (detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile) come Jannik.
Fonte: Treccani.it
______________