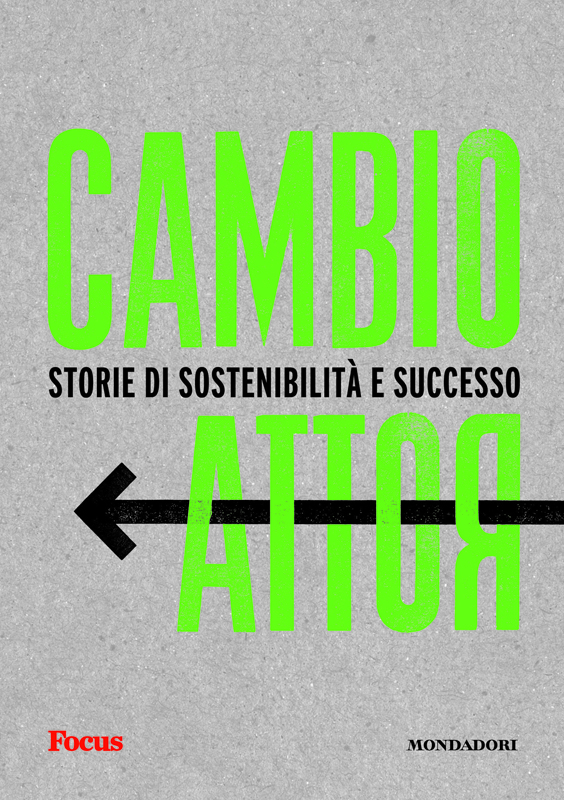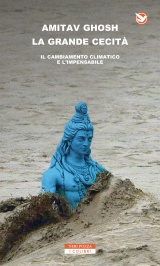Nei primi anni del XXI secolo Amitav Ghosh lavorava alla stesura de Il paese delle maree, il romanzo che si svolge nelle Sundarban, l’immenso arcipelago di isole che si stende fra il mare e le pianure del Bengala.
Occupandosi della grande foresta di mangrovie che le ricopre, Ghosh scoprì che i mutamenti geologici che ciclicamente vi avvenivano – un argine poteva sparire nell’arco di una notte, trascinando con sé case e persone – stavano diventando qualcos’altro: un cambiamento irreversibile, il segno di un inarrestabile ritrarsi delle linee costiere e di una continua infiltrazione di acque saline su terre coltivate.
Che un’intera area sotto il livello del mare come le Sundarban possa essere letteralmente cancellata dalla faccia della terra non è cosa da poco. Mostra che l’impatto accelerato del surriscaldamento globale è giunto ormai a minacciare l’esistenza stessa di numerose zone costiere della terra.
La domanda, per Ghosh, nacque perciò spontanea. Come reagisce la cultura e, in modo particolare, la letteratura dinanzi a questo stato di cose? La risposta è contenuta in questo libro in cui l’autore della trilogia della «Ibis» ritorna con efficacia alla scrittura saggistica.
La cultura è, per Ghosh, strettamente connessa con il mondo della produzione di merci. Ne induce i desideri, producendo l’immaginario che l’accompagna….continua a leggere
Leggi anche l'intervista di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi ad Amitav Ghosh su "il Tascabile"