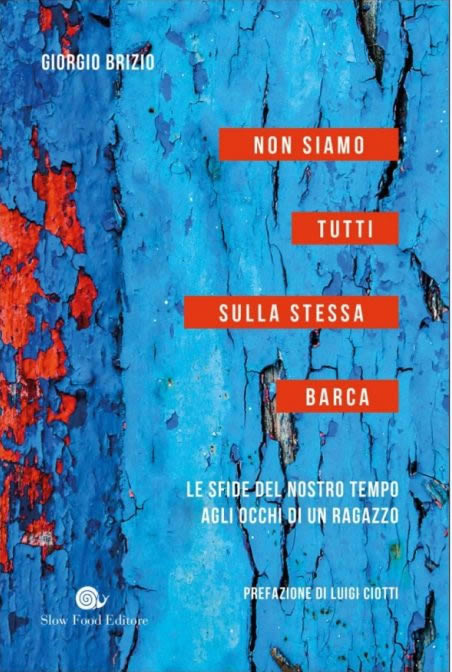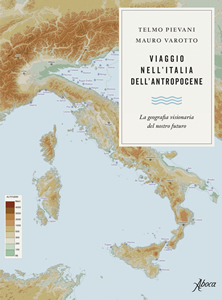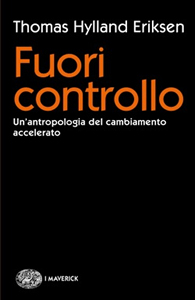Un'antropologia del cambiamento accelerato
Antropologo norvegese, Thomas Hylland Eriksen analizza le contraddizioni di fondo della nostra epoca a cui, dice, va assegnato il nome di Antropocene in quanto l’impronta dell’uomo è predominante su tutto a causa dell’incremento esponenziale delle sue attività. Il libro si fonda sull’assunto che il cambiamento globale accelerato, che per decenni ha destato entusiasmi di sviluppo e progresso, non ha eliminato al suo interno contrasti e tensioni su situazioni economiche e ambientali, violenze settarie, estremismo, povertà e disuguaglianze. Anzi li ha accentuati ponendoci di fronte a realtà molto gravi e difficili da risolvere. Da qui il titolo del libro.
Le forze del progresso si sono rivelate un’arma a doppio taglio, da una parte sviluppo, dall’altra imprevisti importanti e gravi. Tra gli esempi: l’energia a buon mercato, che ha rappresentato la nostra salvezza, oggi ci costringe a fare i conti con la distruzione ambientale e il cambiamento climatico. Oppure il profondo contrasto tra i vantaggi socio economici del mercato globale e i grossi problemi che ne sono derivati nell’affrontare e gestire i flussi vertiginosi degli esseri umani, turistici e immigratori. La conseguenza è che spesso la risposta politica si chiude nel locale e quindi nel ritorno alla chiusura dei confini o in interventi che assecondano paure ataviche. Per Eriksen bisogna invece combinare insieme prospettiva individuale e visione globale. “Il macro e il micro, l’universale e il particolare, devono essere visti come due lati della stessa medaglia. L’uno non ha senso senza l’altro…”. I temi del libro sono affrontati con il punto di vista dell’antropologo. Per esplorare le percezioni locali della globalizzazione e le relative risposte non c’è metodo migliore della ricerca etnografica sul campo, dice Eriksen, in quanto l’etnografia è l’unica tra i metodi delle scienze sociali a fornire sia “la finezza del dettaglio quanto il capitale interpretativo”. Però i metodi dell’etnografia, che è profonda e ampia per la comprensione dei mondi di vita umani, da soli non bastano a comprendere e risolvere le crisi globali. Per affrontare il grande dibattito sul genere umano che ha preso vita all’inizio del XXI secolo, ci vuole anche la conoscenza adeguata dei contesti statistico, storico e macrosociologico. Con questa prospettiva Erikson, in un testo che non è, come lui dice, un documento scientifico, dà il suo contributo alle problematiche dell’Antropocene, prendendo in esame temi quali l’energia, la mobilità, l’urbanizzazione eccessiva, i rifiuti, il sovraccarico di informazioni e, nell’ultimo capitolo, i conflitti di scala con particolare attenzione alla comprensione del surriscaldamento.
Etta Artale