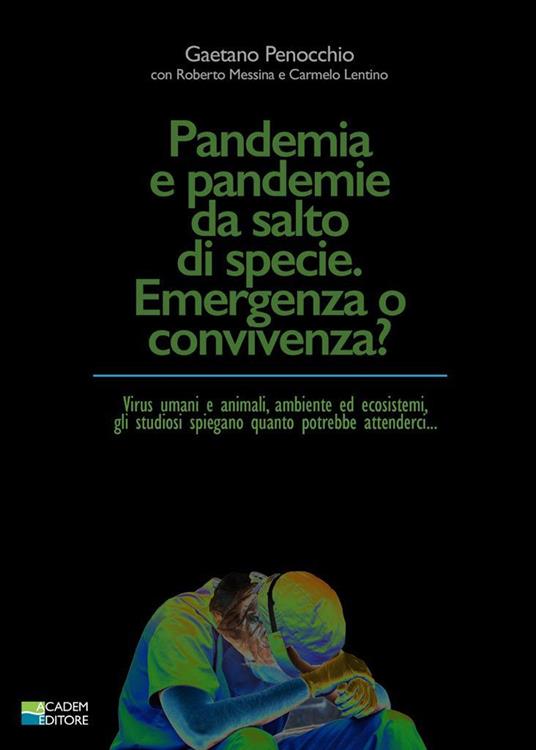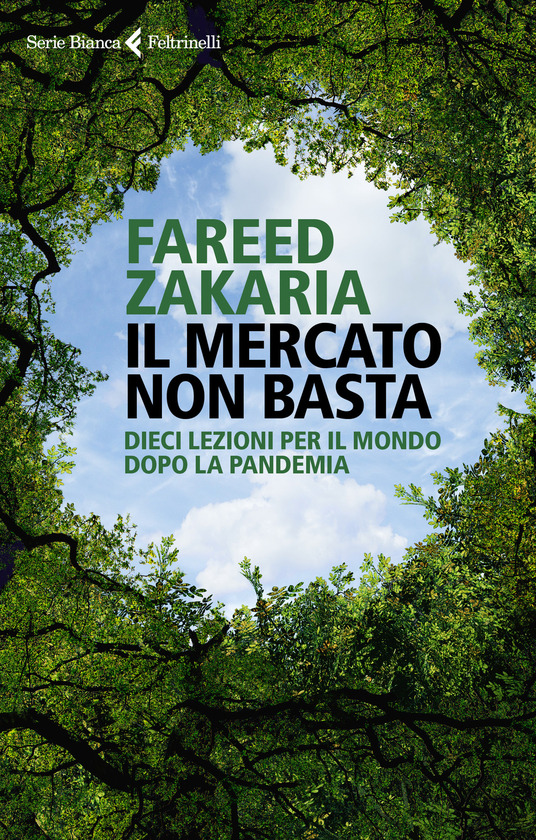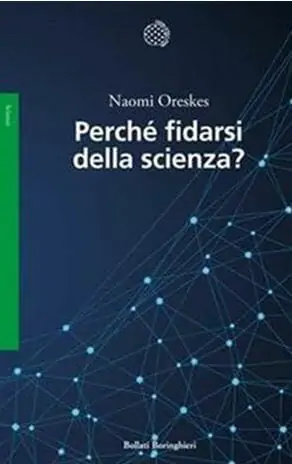Pandemia e pandemie da salto di specie. Emergenza o convivenza?
Academ Editore
Virus umani e animali, ambiente ed ecosistemi, gli studiosi spiegano quanto potrebbe attenderci…
La "questione pandemia": emergenza o convivenza? È possibile che il futuro possa obbligarci ad una sorta di coesistenza, o almeno di coabitazione, con sempre più "ravvicinate" e rinnovate crisi sanitarie pandemiche? Un'eventualità e un'ipotesi allarmanti e preoccupanti, ora che è di dominio pubblico il fatto che una volta superata l'emergenza da Covid-19, il domani potrebbe rivelarsi altrettanto complicato….(continua a leggere)