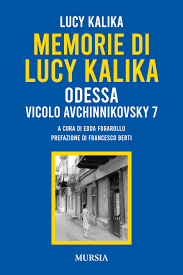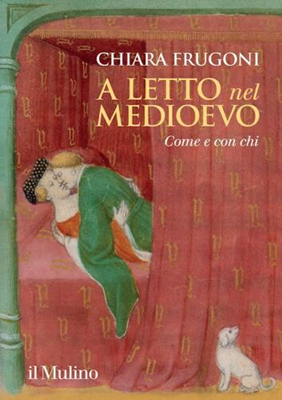MEMORIE DI LUCY KALIKA. ODESSA VICOLO AVCHINNIKOVSKY 7
A cura di Edda Fogarollo. Prefazione di Francesco Berti
Grazie al prezioso lavoro di Edda Fogarollo, appassionata storica dell’ebraismo e della Shoah, sono state pubblicate in Italiano “Le memorie di Lucy Kalika”, la testimonianza drammatica di una giovane ebrea ucraina sfuggita allo sterminio nazista rimanendo nascosta per 820 giorni – dal 24 ottobre del 1941 fino alla liberazione di Odessa il 10 aprile del ’44 – in una angusta cantina segreta sotto la cucina del suo appartamento nel vicolo Avchinnikovski 7 di Odessa. Con lei la sorella, la madre e poche altre persone. Ci chiediamo come la sopravvivenza all'Olocausto sia stata possibile, ma la prima a chiederselo è proprio lei, Lucy Kalika: “Come siamo sopravvissute? Perché non siamo state sterminate insieme a centinaia di migliaia di ebrei?”. La risposta si può forse trovare nelle brevi emozionanti pagine che si leggono tutto d’un fiato e lasciano il sapore amaro della criminalità nazista e insieme la gioia per un esito felice reso possibile dall’aiuto di persone che con la loro complicità per più di due anni hanno rischiato la vita senza cedere alla paura. Sono le vicine di casa Olga ed Elena Kantorovich. Il loro coraggioso aiuto quotidiano ha alimentato la speranza della liberazione in chi sottoterra viveva in condizioni disumane. Kalika scrive il libro a 84 anni, considerando sua missione far conoscere la verità. Le figlie hanno trovato tra i suoi documenti questo appello ai lettori da lei firmato nel 2013, anno in cui è uscito il libro in versione inglese: “Caro lettore, il mio libro è la mia testimonianza: un altro documento accusatorio della tragica storia dell’Olocausto”. Quanto mai attuale oggi che Liliana Segre teme con amarezza la dimenticanza del genocidio: «Una come me ritiene che tra qualche anno ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella».
Il libro non è solo importante per le pagine autografe di Kalika, ma anche per gli altri approfondimenti di cronaca e storia, dalla prefazione di Francesco Berti, docente dell’Università di Padova, all’Introduzione di Edda Fogarollo, alle pagine delle figlie che ci informano sulla vita, il carattere e la professione di medico della madre morta a 91 anni, alla testimonianza di Ariel Viterbo, che racconta di una simile esperienza di sopravvivenza vissuta e testimoniata per iscritto da sua madre. In conclusione l’interessante appendice su Odessa, sempre di Edda Fogarollo: “La Perla del Mar Nero e il suo DNA italiano”. Un valore aggiunto al libro sono poi alcune fotografie della protagonista in anni diversi della sua vita, le foto dei luoghi e degli ambienti in cui avvennero i fatti e quelle di alcuni documenti scritti di proprio pugno da Lucy Kalinka a sostegno della sua storia.
Etta Artale