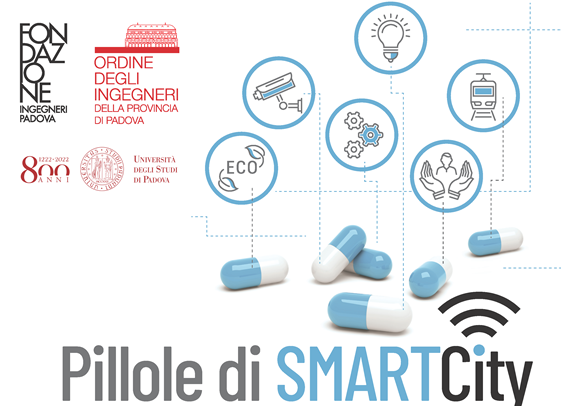Un nuovo polo sanitario nelle vicinanze del policlinico della città del Santo. L’Università di Padova istituisce il primo insegnamento in Italia dedicato alle cure palliative per i minori
Nascerà a Padova il nuovo hospice pediatrico. tremila metri dedicati a bambini e loro famiglie. Parte il fundraising per finanziare l’opera.
Dodici stanze, attrezzate con le più moderne tecnologie, per ospitare altrettanti bambini. Spazi dedicati al personale sanitario dove aggiornarsi e stabilire la migliore strategia per le terapie. Appartamenti per ospitare i familiari dei giovani pazienti, in modo da rendere loro più confortevole possibile la permanenza in città. Ed è proprio a Padova, la città italiana dove è nato il primo hospice pediatrico nel 2008, che si realizzerà il progetto "Nuovo Hospice Pediatrico – Centro di Riferimento regionale per le Cure Palliative e terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto".
Nascerà così un nuovo polo sanitario dedicato alle cure palliative per bambini. Grazie all’impegno di Regione del Veneto, che metterà a disposizione gli immobili, e Azienda Ospedale – Università di Padova, l’attuale sede dell’hospice, in via Ospedale Civile, verrà sostituita da una struttura più ampia e diffusa. Le nuove 12 stanze, al posto delle attuali 4, saranno ospitate in una struttura in via Falloppio, nel cuore della città e a pochi passi dal policlinico universitario. Un altro immobile adiacente al primo, con entrata da via Sant’Eufemia, sarà punto di riferimento per il personale sanitario. Ma il progetto non si ferma qua: in via San Massimo saranno ristrutturati degli appartamenti a disposizione per le famiglie dei giovani pazienti. Ma per far diventare realtà il progetto del nuovo hospice pediatrico c’è bisogno di risorse economiche. Ed è su questo frangente che, in particolare, si sta muovendo l’associazione "La miglior vita possibile". Realtà nata nel 2018, a Padova, per promuovere lo studio e la diffusione della cultura si pone come propria finalità quella di migliorare la condizione di salute e di vita della popolazione pediatrica che ricorre alle cure palliative.
"La miglior vita possibile" lancia quindi una raccolta fondi rivolta a tutti: istituzioni, enti pubblici e privati, mondo dell’associazionismo e cittadini, per raccogliere un’ingente somma da destinare alla realizzazione del progetto.
I numeri delle curie palliative pediatriche in Italia
Padova rimane uno dei cuori pulsanti italiani per le cure palliative pediatriche, mostrando grande attenzione per una tipologia di assistenza che ha numeri importanti nel nostro Paese. Sono infatti 35mila i bambini eleggibili alle curie palliative pediatriche, dei quali più di un terzo, 12mila, necessitano di terapie specialistiche. Il Veneto ha già una rete capillare molto ben sviluppata: 250 bambini sono presi in carico ogni giorno, con prevalenza all’assistenza domiciliare, a fronte comunque di una stima di 900 minori che necessiterebbero di cure. Numeri che fanno intuire l’importanza di strutture come quella nata a Padova (al momento una delle sette in Italia) alla quale il progetto del nuovo hospice pediatrico vuole dare ora una nuova veste. «C’è bisogno di un cambio culturale – conclude Zaccaria –. Di cure palliative pediatriche, infatti, si fa ancora troppa fatica a parlare. Siamo invece davanti a giovani pazienti che hanno il diritto di avere cure adeguate in strutture altrettanto adeguate, che hanno il diritto di coltivare i loro sogni e le loro speranze, di condurre un’esistenza piena circondati dai loro affetti più cari, di portare avanti, quindi, per tutto ciò che è possibile, le loro storie di vita. Di vita, sottolineo, parliamo quando raccontiamo degli hospice pediatrici. È fondamentale quindi superare l’approccio prettamente pietistico che si ha quando si tratta questo argomento. È importante invece porci in altri termini: quelli del diritto di vivere una vita piena. Un obiettivo che, va da sé, possiamo perseguire solo grazie a un rapporto stretto e collaborativo con le istituzioni, in particolar modo quelle deputate all’attività assistenziale».
Il primo insegnamento sulle cure palliative pediatriche in Italia
C’è un’altra importante novità che arriva dal territorio patavino. L’Università di Padova, infatti, ha istituito il primo insegnamento in Italia dedicato alle cure palliative pediatriche. Sarà attivo dal 2023 e andrà a completare l’offerta formativa dell’ateneo patavino, che già prevede un master dedicato alle cure palliative pediatriche e una scuola di specializzazione, di altrettanto recente istituzione, sul tema prezioso per pazienti e famiglie, delle cure palliative nel life-span.
Tutte le informazioni sul fundraising si possono trovare sul sito
costruiamo.lamigliorvitapossibile.it.