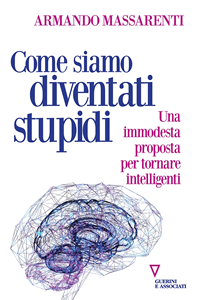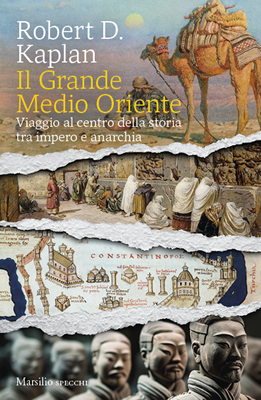a cura di Andrea Pase e Paolo Giaretta
Autori: AA. VV.
Pagine 420
Formato 14,8 x 21 cm
Edizioni Bette 2023
Prezzo di copertina € 26,00
ISBN 9791280564221
La copertina di questo saggio sembra fornire qualche indizio: quattro disegni/simboli non possono essere solo una scelta artistica ma …quartieri! Non ci stupiamo certo di un plurale riferito a una città, chi conosce Padova comprende bene quel plurale. Padova è storicamente, geograficamente, strutturalmente più di una!
Attraverso l’utilizzo delle carte storiche in coordinamento con i Geographic Information System (GIS) gli autori e collaboratori consegnano al lettore uno studio geostorico dettagliato. Ludovico Maurina descrive un esempio molto significativo che riguarda “Il Guasto” realizzato a partire dal 1509 e completato nel 1540. Guasto/spianata che coinvolge una vasta area, calcolata dal perimetro delle mura, entro cui furono distrutte sistematicamente le coltivazioni, le essenze arboree e gli edifici per evitare che eventuali assedianti trovassero riparo dalle artiglierie poste sui nuovi bastioni. I sobborghi che si trovavano fuori dalla nuova cinta muraria furono letteralmente cancellati. Questo evento storico rimane nella toponomastica, basti pensare a Via Guasti che costeggia il parco dei Salici in zona Guizza. La gran carta del padovano del 1780 trasmette la memoria del Guasto con i cippi che ne indicavano il limite, i cosiddetti “termini della Spianata”.
Ma ora, accompagnati dagli autori, andiamo a “leggere” e conoscere i quattro quartieri di Padova.
Partiamo dal cerchio arancione adottato come simbolo del quartiere 2 “Arcella” quasi a rappresentare un’isola circondata da strade, autostrade e ferrovie. Si trova a ridosso della ferrovia Venezia-Milano, a nord-est della stazione. Nel testo si trovano le elaborazioni, curate da Maria Petriccione: 1:15.000 Basemap-IGM fogli Padova/Vigodarzere-1890 delle aree della città di Padova interessate dai bombardamenti durante la prima guerra mondiale, e quella 1:15.000 Basemap-IGM fogli Padova/Vigodarzere -1935 riguardante i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, durante i quali Arcella è stata completamente rasa al suolo.
La storia di questa area geografica, curata da Gabriele Perin, risale al V secolo a.C.. Testimonianze dell’età veneta antica si trovano tra Piazzola sul Brenta e Cadoneghe in direzione Nord ovest sud est, la stessa percorsa dall’idrografia e dalle falde acquifere. Nel testo sono ricostruite in dettaglio le possibili deviazioni del Brenta. Attualmente il quartiere, espanso in tutte le direzioni, si connota soprattutto per l’eterogeneità, densità e concentrazione della popolazione.
Il quadrifoglio verde rappresenta la geografia a ovest della città. Il quartiere è stigmatizzato con quattro foglie a significare quattro nuclei abitativi cresciuti intorno a quattro direttrici che collegano Padova alla Valsugana, alle risorgive, a Vicenza e ai Colli Euganei. L’autore di questo capitolo, Ludovico Maurina, si sofferma lungo queste quattro direttrici a farci immaginare dove ci portano, ma soprattutto attraverso quali paesaggi. A questi dettagli paesaggistici seguono quelli storici che in questo caso ci portano indietro alla protostoria, media età del Bronzo, XVI secolo a.C. fino ai primi secoli d.C. In questo caso i ritrovamenti sono frutto dell’archeologia subacquea condotta su Bacchiglione, canale Brentella e Brenta e annoverano circa 3000 reperti.
L’area a sud della città Bassanello e Guizza, quartiere 4, è rappresentata da una foglia stilizzata che la storica Stella Gentilini individua osservando la carta dove i confini sembrano disegnare una foglia d’acero le cui nervature richiamano i canali, vie navigabili, strade, linee del tram, scoli, vie ciclopedonali. Un complesso rapporto tra natura che permane e uomo che si appropria degli spazi. La storia di questo territorio è antica, la rete stradale risale al II secolo a.C. con il tracciato della via Emila Altinate che sovrapponendosi alla via Annia collegava Aquileia raggiungendo l’entroterra passando proprio per Padova e collegandosi verso sud con Adria. Il sacco longobardo del 602 fece di Padova un cumulo di rovine, ed è proprio in questo periodo che la natura riprende i suoi spazi con gli alberi che in qualche centinaio d’anni formano i boschi planiziali lasciando a quest’area un nome “Guizza” patrimonio immateriale lasciato dai longobardi “Whiza” che significa bosco.
Roberto Basso e Camillo Olivati, esaminando la cartografia pensano come simbolo per il quartiere 3 a un ventaglio, il cui perno corrisponde al grande fagiolo del Piazzale Stanga e le stecche rappresentano le direttrici viarie. Il toponimo si presta a diverse interpretazioni. Una prima ipotesi può essere legata alla sbarra di legno, in Veneto stanga, che era collocata in prossimità dell’ufficio del dazio che regolava l’accesso alla città di Padova. Il quartiere è forse il più recente dal punto di vista abitativo, scarsi sono gli elementi che riportano al passato più o meno recente. Si può escludere solo il “Ponte dei Graissi” la cui presenza risale al XIII secolo, il termine si riferisce ai graticci di vimini con cui era realizzato il ponte prima della costruzione in pietra, ma ci sono anche altre ipotesi non facilmente verificabili. Gli autori descrivono dettagliatamente le trasformazioni degli ultimi due secoli con l’avvento dell’industrializzazione che nel novecento porterà all’origine delle famose Officine Meccaniche Stanga e alla successiva ZIP, Zona Industriale di Padova. Si tratta di un quartiere vasto e in continuo cambiamento non solo dal punto di vista produttivo ma anche sociale, culturale e di aggregazione.
Questo saggio pur nella complessità delle ricostruzioni cartografiche e storiche offre al lettore una visione completa delle Padove considerate.
Nella mia lettura ho spesso prediletto le “radici” che stanno alla base dei diversi nuclei abitativi e che permettono la ricostruzione di una storia complessa e con diversi intrecci culturali, sociali e produttivi. Tuttavia, un lettore attento e curioso, trova nel testo ampi dettagli sulle peculiarità della Padova attuale.
Alberta