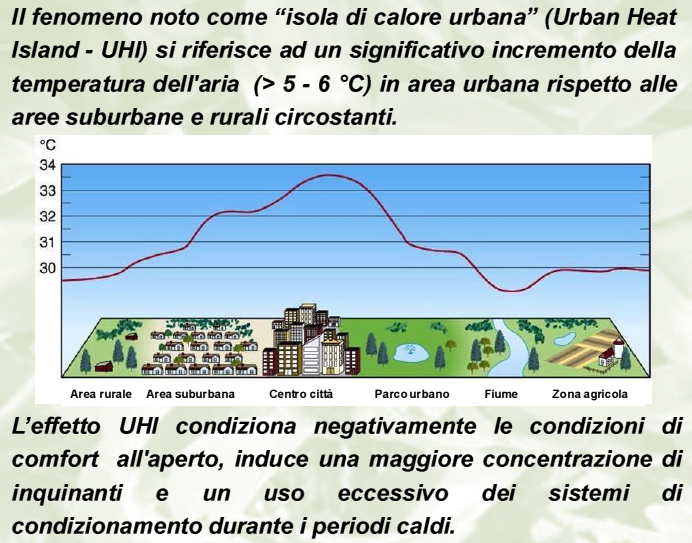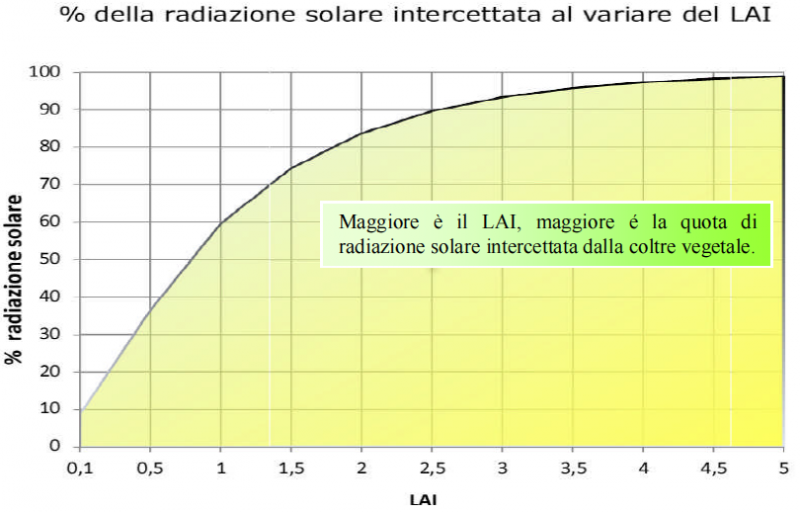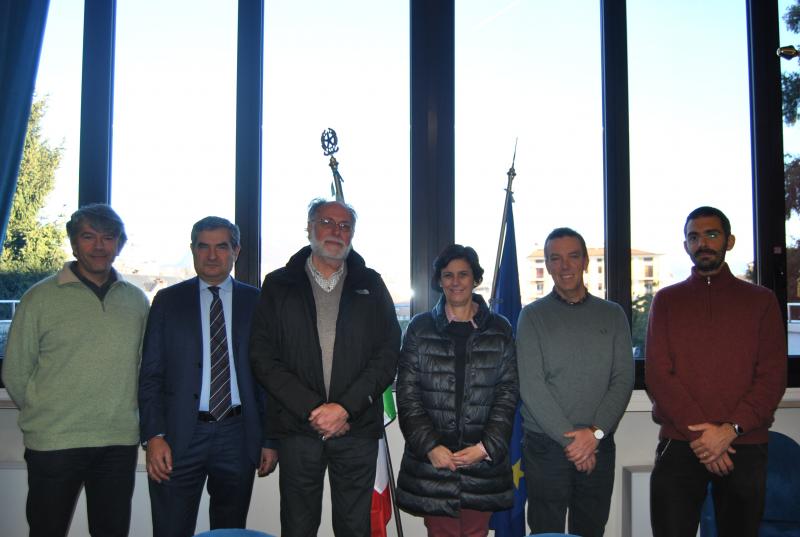Approvata la Strategia europea per il riciclo della plastica. Entro il 2030 il 100% degli imballaggi di plastica sarà riciclabile
La Commissione Europea lancia la prima Strategia europea per il riciclo della plastica: entro il 2030 il 100% degli imballaggi di plastica sarà riciclabile. Da gennaio la Cina sospende l’importazione di rifiuti plastici dall’Europa. Commenti sostanzialmente positivi da parte delle Ong (Organizzazioni non governative). WWF: “Bisogna agire prima del 2030”.
Una strategia comune per il riciclo della plastica
L’Unione europea “dichiara guerra” alla plastica. Il 16 gennaio scorso la Commissione europea ha approvato la prima Strategia europea per il riciclo della plastica. La nuova Strategia, prevista dal Pacchetto europeo sull’economia circolare (approvato ad aprile 2017), prevede di riciclare e rendere riutilizzabili tutti gli imballaggi di plastica presenti sul mercato europeo entro il 2030, di ridurre l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso e limitare l'uso intenzionale di microplastiche. Secondo la Commissione Europea, ogni anno in Europa si generano oltre 25 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, di cui meno del 30% viene avviato al riciclo, il 39% viene incenerito e il restante 31% smaltito nelle discariche. A questo proposito, la Commissione europea sottolinea che la produzione di plastica e l’incenerimento dei rifiuti plastici sono responsabili, a livello globale, dell’emissione di oltre 400 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Grandi quantità di rifiuti plastici finiscono poi negli oceani e nei mari di tutto il mondo, provocando considerevoli danni agli ecosistemi. A tal proposito, la nota rivista internazionale Science riporta che ogni anno vengono gettati negli oceani circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, di cui solo 8 mila tonnellate vengono recuperate da associazioni e gruppi di volontari. Ciò comporta gravi conseguenze per gli organismi marini che, mangiando per errore le microplastiche (granuli, fibre e frammenti delle dimensioni di meno di 5 mm di diametro), che si generano a causa della degradazione della plastica, si procurano ferite e/o malattie. In particolare, lo studio pubblicato su Science dal gruppo di ricerca diretto da Joleah Lamb, ricercatrice della Cornell University di Ithaca (USA), stima che ci siano nelle acque mondiali almeno 11,1 miliardi di oggetti di plastica che rappresentano un pericolo per i 124.000 coralli (Figura 1) che costituiscono le 159 barriere coralline presenti in alcuni dei paesi della regione asiatica (Asia-Pacific region), bagnati dall’oceano Pacifico: Myanmar, Tailandia, Indonesia, Australia. Il gruppo di ricerca della Cornell University, inoltre, stima che la quantità di inquinanti di plastica sulla barriera corallina aumenterà di altri 15 miliardi entro il 2025.

Figura 1. Coralli inquinati da residui plastici
Il documento ufficiale, che illustra la nuova strategia da mettere in atto contro il consumo indiscriminato di plastica, riporta che ogni anno finiscono nelle acque di tutto il mondo tra 5 e 13 milioni di tonnellate di plastica, rispettivamente l’1,5% e il 4% della produzione mondiale di plastica (nella sola Unione Europea tra le 150 e le 500 mila tonnellate). Tra queste una quantità compresa tra le 75 e le 300 mila tonnellate è rappresentata da microplastiche. Dati allarmanti questi, ai quali l’Unione europea ha deciso di rispondere concretamente lanciando una Strategia a lungo termine – al 2030 – che promuova politiche comuni volte alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento da plastica e spinga verso la crescita e l’innovazione dell’industria della plastica, settore che occupa oggi 1,5 milioni di lavoratori in Europa (dati della Commissione europea).
La nuova strategia nel dettaglio
La nuova Strategia europea per il riciclo della plastica cambierà la progettazione, la realizzazione, l'uso e il riciclo dei prodotti nei paesi dell’Unione europea. I principali obiettivi della Strategia sono:
- Rendere redditizio il riciclaggio per le imprese. Verrà sviluppato un sistema di raccolta differenziata e di smistamento dei rifiuti comune in tutti i paesi membri dell’Ue. In questo modo sarà possibile risparmiare circa un centinaio di euro per tonnellata di rifiuti plastici raccolti e si creerà valore aggiunto per un'industria delle materie plastiche più competitiva e resiliente;
- Ridurre i rifiuti plastici. La normativa europea ha già favorito una significativa riduzione dell'uso di sacchetti di plastica in diversi Stati membri. I nuovi piani si concentreranno ora su altri prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Per questo, saranno sostenute campagne di sensibilizzazione nazionali e definite nuove norme di applicazione che saranno proposte a livello di Ue nel 2018;
- Un’etichettatura comune per le plastiche biodegradabili e compostabili. La Commissione europea adotterà nuove misure volte a limitare l’uso delle microplastiche;
- Combattere la dispersione di rifiuti in mare. Ci saranno nuove disposizioni relative agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti plastici intese a garantire che i rifiuti generati a bordo di imbarcazioni o raccolti in mare non siano abbandonati, ma riportati a terra e lì adeguatamente gestiti. Sono inoltre previste misure volte a ridurre l'onere amministrativo che grava sui porti, le navi e le autorità competenti;
- Maggiori investimenti in innovazione tecnologica. Sono previsti 100 milioni di euro di finanziamenti ulteriori per lo sviluppo di materiali plastici più facilmente avviabili al riciclo. I processi di riciclaggio saranno resi più efficienti e sarà più facile tracciare e rimuovere le sostanze pericolose e i contaminanti dalle materie plastiche riciclate;
- Stimolare il cambiamento in tutto il mondo. Oltre a fare la propria parte, l'Unione europea lavorerà con i suoi partner in tutto il mondo per proporre soluzioni globali e sviluppare standard internazionali.
La Cina sospende l’importazione di rifiuti dall’Europa
Secondo dati delle Nazioni Unite, nel 2016 la Cina e la regione amministrativa speciale di Hong Kong hanno importato da Europa, Stati Uniti e Giappone circa 10,3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, pari al 70% dei rifiuti (plastici) raccolti e selezionati in tutto il mondo. Il mercato dell’import dei rifiuti in Cina valeva nel 2016 circa 21,6 miliardi di dollari (4,6 miliardi nella sola Hong Kong). Nel 2017 il Governo cinese aveva notificato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che da gennaio 2018 avrebbe imposto divieti all’importazione di 24 tipologie di materiali riciclabili, raggruppabili in quattro categorie: plastica, carta straccia, rifiuti tessili e scorie di alcuni minerali. La recente misura è in linea con nuovi piani annunciati dal Governo cinese per proteggere l’ambiente dai rifiuti sporchi o contenenti sostanze inquinanti e pericolose, che spesso giungono nei porti del Paese. In una nota ufficiale, pubblicata nei giorni scorsi, il Governo di Pechino ha inoltre annunciato che da marzo saranno intensificati i controlli sulla qualità dei rifiuti importati dall’estero.
La recente chiusura delle “frontiere” cinesi all’importazione dei rifiuti prodotti in Europa avrà effetti significativi sull’industria europea del riciclaggio. Finora, solo il 15% della plastica made in Ue riciclata rimaneva all’interno dei confini europei, mentre l’85% veniva inviato in Cina per essere trattato. L’importazione di rifiuti plastici verso la Cina è incominciato a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, quando il Paese ha iniziato a importare rifiuti solidi dall’estero per alleviare la carenza di alcune materie prime. Nel corso degli anni si sono sviluppate nel Paese grandi aree di lavorazione e smaltimento dei rifiuti, ubicati soprattutto nelle provincie di Canton, Zhejiang e Shandong, aree costiere e principali porti cinesi. Tuttavia, il mercato dell’import di rifiuti destinati al riciclo è cresciuto notevolmente, in concomitanza con una maggior produzione di plastica a livello globale, e la Cina è diventata la prima destinazione di spazzatura per altri paesi (Figura 2). La recente decisione del Governo cinese potrebbe però cambiare presto le cose e giocare un ruolo chiave nell'indirizzo della politica industriale globale.

Figura 2. Discarica a Nanjing (“Nanchino”), una delle più importanti città del Paese, considerata il secondo polo commerciale della Cina orientale dopo Shanghai
L’Unione europea fissa nuovi obiettivi
La nuova stretta sull’importazione dei rifiuti da parte della Cina preoccupa in particolare l’Unione europea che adesso dovrà mettere in campo nuove misure per il riciclo e il riutilizzo dei prodotti, in particolare, dei prodotti di plastica. In questa direzione, l’Unione europea ha già approvato il Pacchetto Ue sull’economia circolare ad aprile 2017 e ha annunciato ora, oltre alla Strategia comune per il riciclo della plastica, anche una serie di obiettivi da aggiungere agli impegni presi precedentemente. Tra questi, gli obiettivi principali sono:
- La nuova Direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta che sarà ora sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione;
- In linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio", la Commissione presenterà la proposta in materia di prodotti di plastica monouso nel corso del 2018;
- I portatori di interessi hanno tempo fino al 12 febbraio 2018 per apportare il proprio contributo alla consultazione pubblica in corso;
- La Commissione europea intende avviare la revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi ed elaborare orientamenti per la raccolta differenziata e lo smistamento dei rifiuti affinché siano pronti nel 2019.
I commenti delle Ong. WWF: “Bisogna agire prima del 2030”
La nuova Strategia annunciata nei giorni scorsi dalla Commissione europea è stata accolta da commenti sostanzialmente positivi da parte delle associazioni ambientaliste di tutto il mondo. Tuttavia, pochi giorni fa il WWF, in un comunicato stampa, ha sottolineato: «l’orizzonte del 2030 appare un po’ troppo lontano rispetto all’effettiva emergenza che la plastica sta assumendo, giorno dopo giorno». Dagli anni ’50 del Novecento ad oggi, fa sapere l’Organizzazione, con la maggior diffusione dell’uso della plastica in tutto il mondo, abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di plastica, di cui abbiamo gettato in natura almeno 6,3 miliardi. Dati estremamente preoccupanti e sui quali il WWF invita i governi di tutto il mondo ad intervenire con urgenza. «Il mondo non può continuare con il modello di spreco attuale», si legge invece in un comunicato stampa di Greenpeace, «basato sulla crescita indefinita in un mondo finito. E invece di trovare nuovi posti dove spedire la spazzatura, governi e industria dovrebbero trovare un modo più semplice per ridurne la quantità». Commenti a parte, è giunto il momento che industria, politica e società civile facciano uno sforzo collettivo nell’adozione di modelli economici più sostenibili basati sul riciclo dei prodotti e sull’economia circolare.
Fonti per approfondire:
- Lamb et al. Plastic waste associated with disease on coral reefs. Science 359, 460–462 (2018) 26 January 2018.